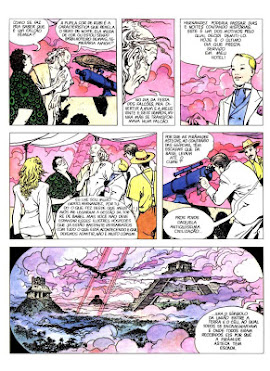Pubblico una breve conversazione con il regista Vittorio De Seta, a proposito delle proprie radici junghiane, che va fuori tema, ma non troppo, dato il grande peso che per un artista ha la ricerca interiore, e la capacita' di vedere e di creare. Dove si scoprono alcune cose della loro breve amicizia, della 500 bianca, erano giovani davvero, per il resto della sua vita Fellini non guido', e della casa di produzione affidata a Fellini che fece molti guai. Ma soprattutto si racconta di Ernst Bernhard che fu lo psicoanalista di entrambi. Si dice che il film Giulietta degli Spiriti (ed in effetti la sceneggiatura lo riporta, ma i titoli di testa e coda no) fosse dedicata proprio al suo psicoanalista e vederlo ne da' conferma a chiunque abbia passato un poco di tempo da quelle parti ... Non sarebbe dunque Otto e mezzo il vero film della psicoanalisi, ma solo di una fase, la fase dello stappo, ma Giulietta, dove in effetti si racconta un'intimita' realista alla biografia almeno sentimentale di Fellini, e dove alla fine si apre una porticina proprio sull'inconscio che porta alla (propria) liberta' ...
Amedeo Caruso: – Lei è stato fra i primi artisti ed intellettuali a conoscere e frequentare Ernst Bernhard. Vuole parlarmene?
Vittorio De Seta: – Lo conobbi nel ’58. Avevo un fratello maggiore, Emanuele che tra il ’56 e il ’58, fu incarcerato e processato per reati di droga. Piuttosto ingiustamente. Ne uscì psicologicamente malconcio. Era instabile, aveva subito traumi in guerra. Lo ospitai per mesi. Uno psicologo incaricato dal tribunale suggerì una psicoterapia. Bernhard venne a casa mia, a Roma, all’Aventino. Sconsigliò un’analisi. La “psicoanalisi” era considerata allora, qui da noi, una scienza esoterica, scientificamente dubbia, tenuta in poco conto, osteggiata dalla Chiesa, dal partito comunista. Tuttavia quel dottore mi colpì. Avevo anch’io problemi psicologici.
Entrò allora in analisi con Bernhard?
Si, analizzavamo i sogni, parlavamo. Cosa insolita, prese in cura anche mia moglie. Ricordo che un giorno, in un momento di tensione, andammo da lui, per aiuto. Ci ricevette senza quasi parlare, preparò un thè e quando tutto fu pronto ci guardammo, con mia moglie: ogni contrasto era svanito. Questo era Bernhard. Faceva in modo che alle conclusioni si arrivasse da soli. Nel 1960 m’incoraggiò, mi “autorizzò” a fare Banditi a Orgosolo. Interrompemmo l’analisi per un anno.
È noto che è stato proprio lei a far conoscere Bernhard a Fellini. Com’era il suo rapporto con l’autore de La dolce vita?
 Dopo il successo di quel film, il produttore, Rizzoli, finanziò la “Federiz”, una casa di distribuzione, affidata a Fellini, con l’intento di favorire il cinema d’autore. Aprirono una sede sontuosa in via della Croce. Ma non funzionò. Fellini, a causa del suo genio, particolare, non riusciva a badare al lavoro degli altri. Non aveva la pasta critica, cinefila, di un Pasolini, un Truffaut, uno Scorsese. Fra l’altro aveva un collaboratore, regista anche lui, al quale non andava bene niente. In poco tempo riuscirono a bocciare Il posto di Ermanno Olmi, Banditi a Orgosolo, già fatti, e Accattone, di Pasolini, pronto per le riprese. Ciononostante diventammo amici. Un giorno eravamo nella sua “500” bianca – che decisamente ci stava stretta, eravamo grossi tutti e due – in un piccolo largo, sopra il Tritone. Ci mettemmo a parlare e lui diede fondo al suo malessere, proprio come si fa con le persone conosciute da poco. Davanti a noi si apriva la prospettiva accattivante di via Gregoriana, dove abitava Bernhard. Un segno del destino? Ricordo come fosse adesso. Mi venne spontaneo dirgli: “Perché non vai da Bernhard?”.
Ci andò in capo a qualche giorno.
Dopo il successo di quel film, il produttore, Rizzoli, finanziò la “Federiz”, una casa di distribuzione, affidata a Fellini, con l’intento di favorire il cinema d’autore. Aprirono una sede sontuosa in via della Croce. Ma non funzionò. Fellini, a causa del suo genio, particolare, non riusciva a badare al lavoro degli altri. Non aveva la pasta critica, cinefila, di un Pasolini, un Truffaut, uno Scorsese. Fra l’altro aveva un collaboratore, regista anche lui, al quale non andava bene niente. In poco tempo riuscirono a bocciare Il posto di Ermanno Olmi, Banditi a Orgosolo, già fatti, e Accattone, di Pasolini, pronto per le riprese. Ciononostante diventammo amici. Un giorno eravamo nella sua “500” bianca – che decisamente ci stava stretta, eravamo grossi tutti e due – in un piccolo largo, sopra il Tritone. Ci mettemmo a parlare e lui diede fondo al suo malessere, proprio come si fa con le persone conosciute da poco. Davanti a noi si apriva la prospettiva accattivante di via Gregoriana, dove abitava Bernhard. Un segno del destino? Ricordo come fosse adesso. Mi venne spontaneo dirgli: “Perché non vai da Bernhard?”.
Ci andò in capo a qualche giorno.
Forse “Otto e mezzo” ebbe inizio proprio lì…
Non c’è dubbio, l’analisi ha avuto un effetto determinante su lui. In seguito ebbi tempo di riflettere. Con La dolce vita, aveva tirato fuori tanti contenuti inconsci e se li era trovati davanti, ancora segreti, dolorosi, insidiosi. Per questo stava male.
Vi siete frequentati in seguito, avete avuto modo di parlare del vostro comune analista?
Questo no, sarebbe stato imbarazzante. Non ci siamo quasi più frequentati perché non riesco a coltivare le amicizie. Non sono mai andato a Fregene. Fellini era un incanto, ti avvolgeva d’attenzione, simpatia, affetto. Poi, da quel momento, tutti e due lavorammo ad un film d’autoanalisi. Non ce lo siamo mai detto. Ci siamo persi di vista.
Sente di aver creato un film – Un uomo a metà – che rappresenta in un certo senso l’ombra di “Otto e mezzo”?
Oddio, che s’intende per “ombra”? Lo diciamo in senso junghiano? Certo che il mio film è stato l’ombra dell’altro, nel senso che Otto e mezzo ha riscosso un successo mondiale, visto da milioni di persone, vinto premi, riconoscimenti, mentre Un uomo a metà è stato distrutto dalla critica, apparso fugacemente nelle sale, insomma, ricoperto d’obbrobrio. Solo Pasolini e Moravia e pochi altri l’hanno sostenuto. Tuttavia a distanza di 40 anni viene ancora proposto. L’anno scorso l’ho rivisto negli Stati Uniti. Ci saranno state 500 persone, (e lì quasi tutte hanno fatto l’analisi), ma alla fine, mi è sembrato, ha suscitato ancora imbarazzo, disagio. È un film casto, eppure in Francia, nel ’67, la censura l’ha vietato ai minori di 18 anni. Che dire? Mi piacerebbe parlarne con Fellini. Certamente mi aiuterebbe a capire. Ma non ha molto senso chiedere a un autore un giudizio sulla sua opera, su quella degli altri. Un film è un tessuto fitto di sentimenti, pensieri, intuizioni. Perché tentare di sezionarlo col bisturi della cosiddetta “ragione”? Vorrei dire solo due cose: Un uomo a metà non è consolatorio e – come gli altri miei lavori – è un “film della realtà”, sia pure psichica.

Sono passati molti anni, cosa le è rimasto, quanto ha influito sull’uomo, sul regista De Seta, l’esperienza psicoanalitica? Pensa che sia stata decisiva per il suo percorso umano e professionale? Crede che il suo ultimo film, Lettere dal Sahara, risenta del lavoro con Bernhard?
Certo, l’influenza della psicanalisi è stata decisiva. Mi ha tirato fuori dal marxismo, dal materialismo. Con l’influenza junghiana ho riscoperto il senso del mistero, mi sono avvicinato alla religione. Mi è sembrato di tornare alla fede. Ma non ero soddisfatto, c’era qualcosa che non andava, non riuscivo a rinunciare alla ragione. Infine sono stato aiutato in modo decisivo dai saggi morali e religiosi di Tolstoj. Vede, è stato un percorso continuo. In sostanza non ho fatto i miei film dopo aver capito le cose, li ho fatti per comprenderle. Non mi sono mai specializzato. I film più che un fine sono stati un mezzo, (per questo sono pochi e diversi tra loro). Ma non vorrei prendermi troppo sul serio. È per dire che proprio il dinamismo, il coinvolgimento continuo, in prima persona, mi hanno impedito di naufragare nel nichilismo. Certo che il mio ultimo film Lettere dal Sahara risente del lavoro con Bernhard. Lui ha segnato la mia vita, in modo decisivo.
Che rapporto ha oggi con la sua vita onirica?
Non sogno più, o almeno non ricordo i sogni. Giorni fa finalmente ne ho fatto uno. L’ho trascritto ma non ho tentato di interpretarlo, come facevo una volta. Mi dispiace.
Questo archivio funziona come una mappa mentale, per associazioni libere, cercate da soli: le immagini solitamente non sono legate ai testi, mentre sempre i link esterni restano esterni, per rispetto della cultura digitale, che questo piccolo spazio testimonia; poi lasciate una traccia del vostro passaggio qui, se volete.